Il romanico
Roma e il Sacro Romano Impero
La scelta “romana” di Carlo Magno è, di
fatto, la scelta del classico. Carlo, così come era in realtà successo per i re
barbari oramai romanizzati, ha Roma come punto di riferimento, un punto di
riferimento politico, statale, culturale, artistico e, come tale, degno di
essere ripreso e attualizzato nel mondo a lui contemporaneo.
Parlare di cultura romana significa, in
un certo senso, prendere posizione critica rispetto alla deriva anticlassica, e
più specificatamente germanica, che aveva caratterizzato i secoli centrali del
cosiddetto Medioevo. La scelta carolina di riproporre l’architettura della
Basilica romana di San Pietro, quale punto di riferimento
architettonico-spaziale per le costruzioni sacre, e quella di divulgare la
cultura attraverso una nuova scrittura, in grado di essere compresa anche da
fasce sociali meno colte e meno ricche, assieme allo sviluppo dei pellegrinaggi
e la nascita di una coscienza borghese, portano ad un profondissimo capovolgimento
di valori e ad una svolta che può essere intesa come “pre-umanistica”.
Pensare a un’esportazione tout court
della cultura figurativa (e non solo), romana, è però fuorviante. Non si
tratta, infatti, di una copia a-critica della romanità, ma di una vera e
propria reinvenzione di essa, di una traduzione, di una trasposizione di Roma
in tutto l’Occidente europeo, ridiventato Impero Romano proprio ad opera di
Carlo. Mai come in questo momento Roma diventa eterna, diventa un mito; Roma
non appartiene ad alcun tempo ma sono tutti i tempi che appartengono a Roma;
Roma non si concretizza in un gusto antiquario per vestigia frammentarie ma rivive
proprio tramite tali frammenti; e Roma
supera la stessa idea che si ha di sé, come lo stesso Impero di Carlo,
scavalcando uno iato durato circa 400 anni, si ricollega immediatamente all’Impero
di Costantino; i tempi si annullano, le distanze si annullano, Carlo Magno è
Costantino come papa Leone III è papa Silvestro e, proprio in quanto Romanorum Imperator Augustus, Carlo si
fa promotore della più grande rinascita dell’Impero, secondaria solo alla
restaurazione del grande Impero Romano ad opera di Costantino.
Spazio dell'Uomo e spazio di Dio nella chiesa romanica
 Dal punto di vista delle costruzioni
sacre (perché l’architettura romanica è in massima parte un’architettura
religiosa), è chiaro che la Roma proposta è quella costantiniana e, in
particolare, quella che produce la Basilica vaticana.
Dal punto di vista delle costruzioni
sacre (perché l’architettura romanica è in massima parte un’architettura
religiosa), è chiaro che la Roma proposta è quella costantiniana e, in
particolare, quella che produce la Basilica vaticana.  La presunta Basilica costantiniana di San
Pietro -formata da un corpo longitudinale plurinavato, preceduto da un
quadriportico e concluso in un transetto rettilineo più o meno sporgente e quindi
in un’abside semicircolare - è l’edificio di riferimento dal IX all’avanzato
XII secolo. Tale edificio, esportato in tutta Europa grazie all’azione dei
monaci benedettini (si ricordi che l’Abbazia di Montecassino riprendeva le
medesime forme e decorazioni di San Pietro in Vaticano), e dei pellegrini, viene
necessariamente realizzato coi materiali propri dei singoli luoghi in cui è
riproposto, da muratori aggiornati a tecniche diverse da situazione a
situazione e, necessariamente, muta in maniera profondissima, pur rimanendo
fedele al modello di base. Si diffonde, quindi, in tutta Europa una struttura
architettonica complessa, composta da parti ben evidenziate (un quadriportico, le
navate, un transetto, un’abside), ma sempre diversa, sempre espressione del
luogo in cui viene realizzata, e ciò non solo dal punto di vista architettonico
ma anche, e soprattutto, socio-culturale.
La presunta Basilica costantiniana di San
Pietro -formata da un corpo longitudinale plurinavato, preceduto da un
quadriportico e concluso in un transetto rettilineo più o meno sporgente e quindi
in un’abside semicircolare - è l’edificio di riferimento dal IX all’avanzato
XII secolo. Tale edificio, esportato in tutta Europa grazie all’azione dei
monaci benedettini (si ricordi che l’Abbazia di Montecassino riprendeva le
medesime forme e decorazioni di San Pietro in Vaticano), e dei pellegrini, viene
necessariamente realizzato coi materiali propri dei singoli luoghi in cui è
riproposto, da muratori aggiornati a tecniche diverse da situazione a
situazione e, necessariamente, muta in maniera profondissima, pur rimanendo
fedele al modello di base. Si diffonde, quindi, in tutta Europa una struttura
architettonica complessa, composta da parti ben evidenziate (un quadriportico, le
navate, un transetto, un’abside), ma sempre diversa, sempre espressione del
luogo in cui viene realizzata, e ciò non solo dal punto di vista architettonico
ma anche, e soprattutto, socio-culturale.
Proprio questo ultimo aspetto è quello
più interessante per poter comprendere appieno il Romanico. Sviluppandosi nei
centri urbani spesso ancora molto giovani, in quanto nati lungo le vie di pellegrinaggio,
la chiesa è espressione del popolo, della nuova classe dirigente – la borghesia
– e, come tale, diventa l’immagine concreta della nuova economia che nasce dopo
la scomparsa delle frontiere europee, un’economia che prevede un continuo
scambio culturale tra luoghi molto distanti tra loro e, quindi, una
contaminazione smisurata di esperienze e influenze dal punto di vista tecnico,
strutturale, architettonico e decorativo.
 La presenza dell’Uomo nella costruzione
della chiesa romanica porta a un mutamento profondo nel rapporto tra esso e il
“divino”. Nella chiesa, espressione della borghesia, necessariamente muta il
rapporto tra il fruitore di essa e ciò che si palesa sull’altare e nell’abside.
Umanizzata fino all’osso, la chiesa non è più semplicemente il luogo che
accoglie la presenza di Cristo, ma è principalmente il luogo dove l’Uomo
incontra la divinità, e la incontra attraverso i mezzi umani, la incontra
attraverso un percorso che deve controllare e misurare, la incontra attraverso
un vero e proprio dialogo con Dio, un dialogo che si svolge in uno spazio
sempre più misurato e, quindi, in un tempo sempre più percepito.
La presenza dell’Uomo nella costruzione
della chiesa romanica porta a un mutamento profondo nel rapporto tra esso e il
“divino”. Nella chiesa, espressione della borghesia, necessariamente muta il
rapporto tra il fruitore di essa e ciò che si palesa sull’altare e nell’abside.
Umanizzata fino all’osso, la chiesa non è più semplicemente il luogo che
accoglie la presenza di Cristo, ma è principalmente il luogo dove l’Uomo
incontra la divinità, e la incontra attraverso i mezzi umani, la incontra
attraverso un percorso che deve controllare e misurare, la incontra attraverso
un vero e proprio dialogo con Dio, un dialogo che si svolge in uno spazio
sempre più misurato e, quindi, in un tempo sempre più percepito. A questo punto è chiaro che analizzare
l’architettura romanica dal punto di vista meramente strutturale, appare fuorviante
e anche limitativo. È vero che lo scambio economico e culturale tra le varie
regioni dell’Impero porta a contaminazioni costruttive, è vero che le stesse
premesse carolingie, volte alla sottolineatura del ruolo dell’Imperatore nel
rapporto col popolo che portavano alla nascita del Westwerk, diventano un
linguaggio desemantizzato che si diffonde in maniera uniforme in tutto
l’Impero, ma è anche vero che è proprio grazie all’intervento del cittadino
nella costruzione del tempio si può riconoscere una serie di eventi architettonici,
da leggere come “necessari” alla presenza dell’Uomo nella casa di Dio.
A questo punto è chiaro che analizzare
l’architettura romanica dal punto di vista meramente strutturale, appare fuorviante
e anche limitativo. È vero che lo scambio economico e culturale tra le varie
regioni dell’Impero porta a contaminazioni costruttive, è vero che le stesse
premesse carolingie, volte alla sottolineatura del ruolo dell’Imperatore nel
rapporto col popolo che portavano alla nascita del Westwerk, diventano un
linguaggio desemantizzato che si diffonde in maniera uniforme in tutto
l’Impero, ma è anche vero che è proprio grazie all’intervento del cittadino
nella costruzione del tempio si può riconoscere una serie di eventi architettonici,
da leggere come “necessari” alla presenza dell’Uomo nella casa di Dio. I linguaggi regionali del romanico italiano
La lettura dello spazio architettonico
della chiesa romanica ora proposto, evidentemente non può prescindere dalle
membrature architettoniche che lo definiscono e lo comprendono ma, allo stesso
modo, dà a esse un valore che non è meramente strutturale ma, essenzialmente,
storico-artistico e umanistico.
Pur essendo strettamente collegata alle
influenze economico-commerciali che determinano l’eterogeneità delle realtà
culturali europee, nella stragrande maggioranza delle chiese romaniche la
presenza dell’essere umano è fondamentale. In maniera diversa: che ciò avvenga
tramite una frammentazione spaziale, tramite una scelta dei soggetti
decorativi, tramite un controllo dimensionale e proporzionale delle singole
parti componenti l’organismo architettonico, sempre appare palese la necessità
di controllare, armonizzare la struttura, rendendola immediatamente
riconoscibile come frutto della razionalità umana.
Le influenze dovute alla situazione
economico-commerciale che caratterizza questo particolare periodo storico e
questa particolare situazione politica, basata essenzialmente sul libero
scambio e sulla libera circolazione di idee, vede il “ritorno a Roma”
esprimersi non solo in linguaggi nazionali ma anche, almeno per quanto riguarda
l’Italia, in particolarismi locali o regionali che possono essere sintetizzati
in :
Romanico lombardo
Romanico padano
Romanico veneto-veneziano
Romanico umbro-marchigiano
Romanico toscano e fiorentino
Romanico pugliese
Romanico normanno-bizantino nel meridione d'Italia
Rinascita paleocristiana nel Lazio e a Roma
Romanico lombardo
Romanico padano
Romanico veneto-veneziano
Romanico umbro-marchigiano
Romanico toscano e fiorentino
Romanico pugliese
Romanico normanno-bizantino nel meridione d'Italia
Rinascita paleocristiana nel Lazio e a Roma

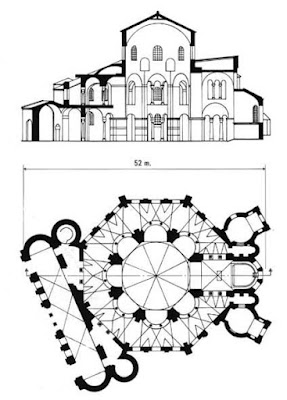
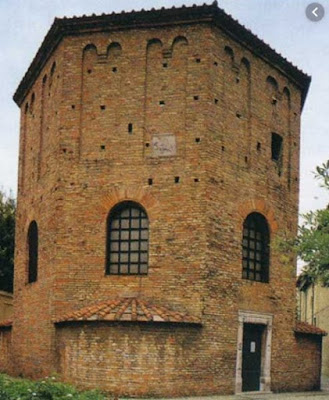
Commenti
Posta un commento