La civiltà cretese
L'isola di Creta si trova lungo un percorso che attraversa tutto il Mediterraneo, dal Medio Oriente, verso l'Occidente (Sicilia, Spagna, Stretto di Gibilterra), e, contemporaneamente in una posizione mediana tra la Penisola balcanica e le coste settentrionali dell’Africa (l’Egitto). Questa situazione geografica, fa sì che l'isola di Creta, fosse un punto di riferimento importantissimo, diventando una sorta di pilone di un immaginario ponte che permette uno scambio certamente economico ma anche un incontro di tipo culturale tra il Medio Oriente e l’estremo occidente del Mediterraneo.
La posizione strategica dell’Isola permetteva, quindi, oltre ad una ricchezza economica impareggiabile anche un concreto incontro tra culture differenti tra loro: quella di origine balcanica, quella egiziana e un'altra formata da un coacervo di realtà mesopotamiche e medio orientali come i Sumeri, gli Assiri, i Babilonesi, i Persiani, gli Ittiti ecc.
Appare chiaro, a questo punto, che la fortuna della civiltà cretese è strettamente legata alla sua posizione geografica e, quindi, al mare. Il mare non è mai un muro, il mare non divide ma lega, il mare permette uno scambio continuo e positivo di tipo commerciale, economico e, quindi, culturale. La comprensione di ciò è necessaria per capire la differenza che si noterà tra la civiltà cretese e quella, pressoché contemporanea, micenea. Quest’ultima, infatti, tipica dell’Argolide, regione situata nel centro del Peloponneso, nella Grecia continentale, territorio montagnoso e impervio, è certamente più diffidente, più chiusa, meno pronta all’accoglienza della diversità, tendente, piuttosto a considerare quest’ultima non come un valore ma come un nemico da combattere.
In conclusione, quindi, è grazie alla posizione geografica, all’attitudine all’accoglienza dello straniero e del diverso che, a partire dal III millennio a.C. e per almeno mille anni, Creta diventerà il luogo più importante, moderno e splendido di tutto il bacino del Mediterraneo
L'archeologia e il Mito.
Dell’isola di Creta sono noti alcuni dei più importanti siti archeologici dell’antichità: tra essi il più noto è certamente il sito di Cnosso, presso l’attuale città di Heraklion, assieme ai siti di Mallia, Agia Triada (Festos) e Agios Nikolaos.
Dell’isola di Creta sono noti alcuni dei più importanti siti archeologici dell’antichità: tra essi il più noto è certamente il sito di Cnosso, presso l’attuale città di Heraklion, assieme ai siti di Mallia, Agia Triada (Festos) e Agios Nikolaos.
In pochi altri luoghi del Mediterraneo i siti archeologici hanno la stessa importanza anche storica che riscontriamo a Creta: della cultura minoica non si hanno fonti storiche, ma solo mitiche, legate alle figure di semidei, di Teseo, di Arianna, del Minotauro, di Minosse, del Labirinto.
Queste figure e questi luoghi legati al mito, grazie all’archeologia, permettono di ipotizzare una loro concretezza; in particolare proprio gli scavi archeologici ci hanno consentito non solo di riconoscere, grazie alla scoperta della cosiddetta “scrittura lineare a” (un sistema di scrittura affiancato ai geroglifici cretesi, di chiara ascendenza egizia), quale sia il vero valore di Minosse ma anche di proporre una periodizzazione della civiltà cretese.
La cronologia
Proprio i risultati degli scavi, guidati dall’archeologo Arthur Evans (1851-1941) ci aiutano a suddividere lo sviluppo della civiltà cretese in 4 grandi periodi, in base allo studio delle emergenze architettoniche (i cosiddetti palazzi, di cui si parlerà in seguito).
Periodo Prepalaziale o Minoico Antico – Tra il 3000 a.C e il 1900 a.C
Periodo Protopalaziale o Minoico Medio – tra il 1900 a.C. e il 1700 a.C.
Periodo Neopalaziale o Minoico Tardo – tra il 1700 a.C. e il 1450 a.C.
Periodo Postpalaziale tra il 1450 a.C. e il 1200 a.C.
Il passaggio dai primi palazzi ai nuovi palazzi avviene a causa di un evento naturale di dimensioni apocalittiche, che gli studiosi tendono a riconoscere nell’esplosione del vulcano di Santorini, nell’attuale isola di Thera. In seguito a tale evento catastrofico i primi palazzi cretesi vennero distrutti e, nel giro di poco tempo, ricostruiti nelle forme più ampie e grandiose che conosciamo adesso.
Proprio i risultati degli scavi, guidati dall’archeologo Arthur Evans (1851-1941) ci aiutano a suddividere lo sviluppo della civiltà cretese in 4 grandi periodi, in base allo studio delle emergenze architettoniche (i cosiddetti palazzi, di cui si parlerà in seguito).
Periodo Prepalaziale o Minoico Antico – Tra il 3000 a.C e il 1900 a.C
Periodo Protopalaziale o Minoico Medio – tra il 1900 a.C. e il 1700 a.C.
Periodo Neopalaziale o Minoico Tardo – tra il 1700 a.C. e il 1450 a.C.
Periodo Postpalaziale tra il 1450 a.C. e il 1200 a.C.
Il passaggio dai primi palazzi ai nuovi palazzi avviene a causa di un evento naturale di dimensioni apocalittiche, che gli studiosi tendono a riconoscere nell’esplosione del vulcano di Santorini, nell’attuale isola di Thera. In seguito a tale evento catastrofico i primi palazzi cretesi vennero distrutti e, nel giro di poco tempo, ricostruiti nelle forme più ampie e grandiose che conosciamo adesso.
I nuovi palazzi di Creta – Il Palazzo di Cnosso.
Non perdendo mai di vista la situazione geografica affatto tipica dell’Isola di Creta e, quindi, l’importanza delle influenze fenicie o egizie nella formazione della cultura minoica, si può affermare con certezza che la praticamente totale messe di informazioni che si ha di questa cultura artistica, deriva dallo studio di ciò che la terra ha restituito nei siti di Cnosso, di Mallia, di Festos (Agia Triada) e di Agios Nikolaos. Principalmente è il Palazzo di Cnosso a permetterci di entrare in contatto vivo con l’esperienza artistica e culturale cretese e di poter individuare connessioni importanti con il mito.
Nonostante l’attuale palazzo sia frutto di una massiccia ricostruzione ad opera degli archeologi americani, la lettura planimetrica di esso permette di avanzare alcune riflessioni importantissime sia sulla qualità intima dell’edificio, collegandolo ai miti legati alla cultura cretese, sia sul suo rispecchiare la vita e la cultura della civiltà minoica.
L’edificio si stende in maniera organica su un pianoro, non mostra alcuna cinta muraria o elementi di fortificazione, ed è composto da un enorme numero di ambienti che si sistemano in maniera irregolare attorno ad un grande cortile rettangolare. Il rapporto col territorio appare immediatamente forte ed essenziale, l’edificio, infatti, non si oppone alla natura, non segna una cesura e non mostra, allo stesso tempo, alcuna soluzione di continuità. Gli ambienti si inseguono senza un ordine preciso e le stesse altezze dell’edificio difficilmente superano quelle degli alberi che lo circondano. Nonostante si noti una via di accesso principale alla grande struttura, non si può asserire che esistesse una vera e propria porta d’accesso, gli ambienti, infatti, si aprivano con loggiati e portici sul territorio circostante lasciando che la natura invadesse gli spazi interni. Una tale situazione architettonica, affatto unica, permette di pensare ad un edificio difficilmente intuibile come “palazzo” all’interno di una “città”, quanto piuttosto di parlare di “città in forma di palazzo” o di “palazzo in forma di città”, espressione concreta di una mentalità e di una gestione della società completamente democratica e assolutamente estranea alle arti della guerra.La complessità e la varietà degli spazi abitativi e non (sono stati riconosciuti alcuni ambienti atti alla conservazione delle derrate alimentari che, evidentemente, servivano al sostentamento dell’intera popolazione), permettono di ipotizzare il riconoscimento, nel palazzo di Cnosso, del mitico labirinto.
La decorazione

 Particolarmente interessante è la decorazione pittorica del palazzo, che contribuiva alla creazione di un luogo abitativo ameno e ospitale. Proprio attraverso lo studio di essa (assieme a qualche traccia architettonica), è possibile riconoscere alcuni ambienti aulici, tra cui una sala del trono e una sala ipostila. In tutti i vani si individua una libertà decorativa, specchio di una cultura libera e aperta al confronto con lo straniero, estranea a codificazioni e a restrizioni anche sociali, che si riconosce in una ricerca di eleganza che si raggiunge attraverso l’utilizzo di colori chiari, linee sinuose, raffigurazioni fitomorfe e zoomorfe (pesci, alberi, anemoni, tori, cani e scimmie), rappresentazioni di processioni, cortei, atleti, ecc. Tale attenzione per la qualificazione degli ambienti più belli del palazzo, che si concretizza con scene processionali, cortei, giochi e danze, ci permette di ricostruire vari aspetti della civiltà cretese, come, per esempio, il modo di abbigliarsi (donne elegantissime – come la cosiddetta “Parigina”, che sfoggiano riccioli, occhi bistrati, labbra rosse, diademi, bracciali anelli e particolarissimi abiti formarti da corpetti aderenti che lasciano scoperto il seno e stringono la vita, mentre le gonne appaiono a balze e di diversi colori, e uomini dal fisico atletico, vestiti solo di una sorta di gonnellino di origine egiziana con i capelli lunghi, che sfoggiano spesso dei cappelli piumati e gioielli, come si nota nel cosiddetto Principe dei gigli), o il modo di relazionarsi alla natura e il rapporto con gli animali. Molte sono le scene di giochi con i tori, che non hanno nulla a che fare con la "tauromachia" ma che vedono atleti volteggiare sul corpo gigantesco dell'animale, di feste da ballo e di cortei.
Particolarmente interessante è la decorazione pittorica del palazzo, che contribuiva alla creazione di un luogo abitativo ameno e ospitale. Proprio attraverso lo studio di essa (assieme a qualche traccia architettonica), è possibile riconoscere alcuni ambienti aulici, tra cui una sala del trono e una sala ipostila. In tutti i vani si individua una libertà decorativa, specchio di una cultura libera e aperta al confronto con lo straniero, estranea a codificazioni e a restrizioni anche sociali, che si riconosce in una ricerca di eleganza che si raggiunge attraverso l’utilizzo di colori chiari, linee sinuose, raffigurazioni fitomorfe e zoomorfe (pesci, alberi, anemoni, tori, cani e scimmie), rappresentazioni di processioni, cortei, atleti, ecc. Tale attenzione per la qualificazione degli ambienti più belli del palazzo, che si concretizza con scene processionali, cortei, giochi e danze, ci permette di ricostruire vari aspetti della civiltà cretese, come, per esempio, il modo di abbigliarsi (donne elegantissime – come la cosiddetta “Parigina”, che sfoggiano riccioli, occhi bistrati, labbra rosse, diademi, bracciali anelli e particolarissimi abiti formarti da corpetti aderenti che lasciano scoperto il seno e stringono la vita, mentre le gonne appaiono a balze e di diversi colori, e uomini dal fisico atletico, vestiti solo di una sorta di gonnellino di origine egiziana con i capelli lunghi, che sfoggiano spesso dei cappelli piumati e gioielli, come si nota nel cosiddetto Principe dei gigli), o il modo di relazionarsi alla natura e il rapporto con gli animali. Molte sono le scene di giochi con i tori, che non hanno nulla a che fare con la "tauromachia" ma che vedono atleti volteggiare sul corpo gigantesco dell'animale, di feste da ballo e di cortei.
L'eleganza e l'architettura
La necessità di perseguire l’eleganza formale vede il sacrificio dell’aspetto più strutturale dell’intero edificio; così come si nota dalla ricostruzione dovuta a Lord Evans, basata sull’analisi anche di alcuni affreschi ora conservati nel Museo Archeologico di Heraklion, ciò che, dal punto di vista architettonico, caratterizzava il palazzo di Cnosso è la grande quantità e varietà di loggiati che si aprivano verso il cortile interno e verso le colline. La struttura dell’edificio appare in realtà fragilissima, i muri sono molto sottili e, principalmente, i loggiati erano sostenuti da colonne di legno di forma conica, stranamente rastremata verso il basso e dipinte di rosso, nero, giallo, bianco, azzurro. Tali colonne, mostrando una grande eleganza, sono la negazione della staticità; la forma slanciata di esse non permetteva un corretto scarico a terra delle forze e quindi non contribuivano in alcun modo a rendere la struttura solida.
La
cultura materiale: la ceramica di Kamares
 Questa
libertà di spirito si ritrova anche nei manufatti: anfore, gioielli, statuine
che provengono in massima parte dagli scavi dei palazzi e da qualche tomba. In
particolare appare estremamente importante il sarcofago proveniente da Festos
(Agia Triada), in pietra e decorato con immagini processionali che ripetono,
ancora, gli schemi decorativi di grande eleganza, ritrovati nelle pitture
murali dei palazzi. I gioielli recuperati dalle tombe mostrano una ricchissima
varietà di immagini fitomorfe e zoomorfe (spesso di provenienza egizia), come
anemoni, scarabei, mosche, api, e tra essi si riconoscono orecchini, diademi,
bracciali e collane la cui forma è ricollegabile agli analoghi gioielli
egiziani.Estremamente importante, sia dal punto di vista decorativo che dal
punto di vista culturale, è la ceramica,in particolare quella proveniente dal
sito di Kamares. Alla poca varietà morfologica (notiamo brocche – oinochoe
- vasi per le derrate alimentari, piatti e anfore), corrisponde una incredibile
varietà e libertà decorativa. Tutte le ceramiche di Kamares presentano,
una assoluta indifferenza da parte dell’artista circa la tettonica
dell’oggetto, non c’è alcuna volontà, infatti, di evidenziare le parti
costitutive di esso (collo, ansa, base ecc), ma la decorazione si stende senza
alcun limite su tutto il corpo del manufatto, mostrando una scelta molto ampia
di soggetti (da decori astratti ondulati e concentrici a foglie, fiori o
semplici bande ondulate). Una delle testimonianze più importanti della ceramica
di Kamares è data dalla “brocca di Gurnià”che utilizza l'immagine del polpo,
formato da un corpo dal quale si staccano otto tentacoli che abbracciano
l'intera area dell’anfora.
Questa
libertà di spirito si ritrova anche nei manufatti: anfore, gioielli, statuine
che provengono in massima parte dagli scavi dei palazzi e da qualche tomba. In
particolare appare estremamente importante il sarcofago proveniente da Festos
(Agia Triada), in pietra e decorato con immagini processionali che ripetono,
ancora, gli schemi decorativi di grande eleganza, ritrovati nelle pitture
murali dei palazzi. I gioielli recuperati dalle tombe mostrano una ricchissima
varietà di immagini fitomorfe e zoomorfe (spesso di provenienza egizia), come
anemoni, scarabei, mosche, api, e tra essi si riconoscono orecchini, diademi,
bracciali e collane la cui forma è ricollegabile agli analoghi gioielli
egiziani.Estremamente importante, sia dal punto di vista decorativo che dal
punto di vista culturale, è la ceramica,in particolare quella proveniente dal
sito di Kamares. Alla poca varietà morfologica (notiamo brocche – oinochoe
- vasi per le derrate alimentari, piatti e anfore), corrisponde una incredibile
varietà e libertà decorativa. Tutte le ceramiche di Kamares presentano,
una assoluta indifferenza da parte dell’artista circa la tettonica
dell’oggetto, non c’è alcuna volontà, infatti, di evidenziare le parti
costitutive di esso (collo, ansa, base ecc), ma la decorazione si stende senza
alcun limite su tutto il corpo del manufatto, mostrando una scelta molto ampia
di soggetti (da decori astratti ondulati e concentrici a foglie, fiori o
semplici bande ondulate). Una delle testimonianze più importanti della ceramica
di Kamares è data dalla “brocca di Gurnià”che utilizza l'immagine del polpo,
formato da un corpo dal quale si staccano otto tentacoli che abbracciano
l'intera area dell’anfora.
Conclusioni
Anche in questo caso notiamo una totale mancanza di schematismo, una scelta per un’espressione artistica leggera e libera, una distanza enorme da un mondo che guarda con diffidenza alla novità e allo straniero; siamo davanti ad una delle culture più interessanti e splendide dell’antichità, talmente tanto superiore alla banalità della guerra da non essere pronta ad affrontare uno straniero nemico che, verso il 1400 si presenterà lungo le coste settentrionali dell’isola invadendola e annientandola completamente: i Micenei. L’arrivo dei guerrieri micenei vedrà la scomparsa totale della splendida stagione artistica cretese, i palazzi verranno definitivamente distrutti, l’isola sarà assoggettata alla cultura peloponnesiaca continuando a sopravvivere, però, in una nuova fase culturale di quest’ultima, contribuendo a creare le basi per la grande civiltà greca.
-->






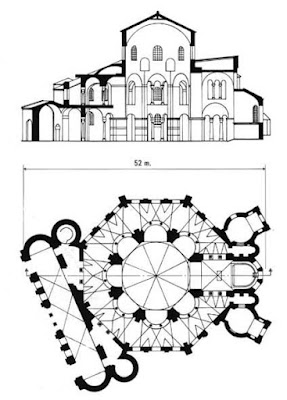
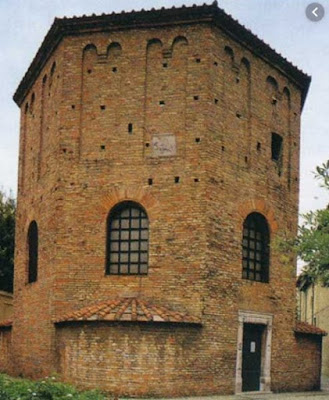
Commenti
Posta un commento