Romanico 3
Il linguaggio romanico viene declinato in vari sotto-linguaggi, in base alle caratteristiche ambientali, alle tradizioni costruttive locali, ai contatti culturali che si intessono ecc. Per questo motivo, per esempio, il romanico veneziano, molto influenzato da Bisanzio - perché Venezia, come Ravenna, è in forte legame con Bisanzio-, è diverso da quello lombardo ed è distante da quello toscano dove, invece, sono evidenti delle forti influenze romane, anche dovute a una vicinanza geografica con Roma.
San Miniato al Monte
Pisa
Roma
La situazione romana è molto interessante. Nonostante, infatti, la massiccia presenza germanica (che si manifesta, principalmente, nella scelta di papi di origine tedesca), l’apporto di novità sostanziali all’architettura della città appare poca cosa. Ciò che invece si impone è proprio una ripresa critica dell’architettura costantiniana (San Pietro o San Paolo), rielaborata essenzialmente in senso dimensionale e, nell’apparato decorativo, una svolta in senso classicista, con un salto di qualità evidente. Alla sottolineatura della necessità della ripresa sistematica dell’architettura paleocristiana, si associa un palese superamento di quella sorta di interpretazione in termini lineari e bidimensionali dell’iconografia romana di V e VI secolo, rappresentata dai grandi mosaici absidali di Santa Pudenziana e dei SS. Cosma e Damiano. Se, infatti, nelle absidi di Santa Cecilia e di Santa Prassede, databili agli anni ’20 del IX secolo, si nota un’evidente distanza formale ma non iconografica dall’abside dei SS Cosma e Damiano, con riduzione delle figure a grafismi bidimensionali, le decorazioni delle strutture di X-XII secolo, mostrano una vera e propria riappropriazione anche della raffinatezza stilistica, propria delle grandi decorazioni musive di IV secolo.
San Clemente
La basilica di San Clemente, datata all’inizio del XII secolo, realizzata per volontà del cardinale Anastasio sull’antica basilica paleocristiana, che aveva a suo tempo rimpiazzato il Titulus Clementis, assieme a Santa Maria in Trastevere e a San Crisogono, è una delle testimonianze più importanti della cosiddetta Rinascita Paleocristiana romana. La basilica riprende senza nessun dubbio le strutture costantiniane, è infatti preceduta da un quadriportico e mostra una scansione interna in tre navate divise da colonne che reggono archi. A differenza delle altre due basiliche trasteverine (San Crisogono e Santa Maria), a San Clemente il transetto non è sporgente ma lo spazio della navata principale appare diviso in due parti, grazie all’inserzione di un pilastro al centro del colonnato (come succede anche a S. Maria in Cosmedin), e semi occupato da un grande bema di chiara ispirazione orientale. Come a Santa Maria in Cosmedin, quindi, l’”antico” riecheggiante a San Clemente è un’epoca vaga, oscillante tra Costantino e Giustiniano, tra evidenze romane e suggestioni culturali e rituali greche. Certamente sono greche le decorazioni delle lastre del bema, così come quelle del pulpito, dove la tecnica dell’abbassamento di fondo evidenzia una raffinatezza eccezionale nella redazione delle immagini, ma altrettanto certamente l’intera struttura architettonica e, principalmente, il mosaico absidale, non lasciano dubbi sull’assoluta romanità della fondazione.
Pur se non generanti alcun arco sulla navata principale, è chiaro che la coppia dei pilastri centrali rimandi alle esperienze di Lomello, di San Miniato e in generale di ambiente ottoniano. A San Clemente, come a Santa Maria in Cosmedin, lo spazio viene decisamente frammentato, proprio per riproporre quel nuovo dialogo tra Uomo e Dio che così tanto caratterizza le nuove esperienze architettoniche del secolo dell’anno 1000.
Ed è proprio al dialogo Uomo – Dio e, principalmente, al ruolo dell’Uomo nella realizzazione delle nuove chiese e nella decorazione di esse, che sembra rimandare il bellissimo mosaico absidale della basilica di San Clemente. Pur riprendendo lo schema compositivo e simbolico paleocristiano, che vedeva la croce al centro della composizione, attorniata o meno da altri personaggi, il mosaico di San Clemente mostra una svolta decisiva nell’interpretazione anche dello spazio simbolico absidale. Il grande mosaico, infatti, ha come punto di riferimento e come elemento discriminante della composizione generale, la Croce. Come a Santa Pudenziana, anche qui la croce si trova al centro, è asse di simmetria e si impone per dimensioni su tutto il resto della decorazione. Ma, a differenza di ciò che succedeva a Santa Pudenziana alla fine del IV secolo, e che sarebbe apparso come punto focale, perno di un sistema dinamico, elemento di grande capacità attrattiva nelle basiliche di piena età costantiniana, la croce di San Clemente non è più una Croce Gemmata, ma mostra un Cristo Paziente inchiodato ad essa.
Pur riprendendo, probabilmente, la crocifissione rappresentata nel V secolo sulla porta di Santa Sabina, la scelta di rappresentare un Cristo Paziente evidenzia la distanza concettuale gigantesca dal Cristo Trionfante, vestito col colobium, di Santa Maria Antiqua, permettendo di individuare proprio nella diffusione del Cristo Paziente il punto di riferimento dei mosaicisti romani.
Ma, quello che risulta assolutamente interessante, e totalmente in linea con la linea di pensiero proto-umanista di cui ci si sta occupando, è la trasformazione della croce gemmata in Cristo Paziente. Non si tratta solo, in questo caso, di riconoscere Cristo come un Dio umanizzato ma, a San Clemente, la morte di Cristo indica la strada verso la resurrezione; la croce non è più conficcata sulla collina del Golgota (come a Santa Pudenziana), ma diventa una croce vivificante: l’albero della vita. Dalla base della croce, infatti, nasce e si dirama su un fondo oro, con girali naturalistici e quasi tridimensionali, un albero ricco di frutti e di fiori, rigogliosissimo, che invade tutta la conca absidale. Accanto a questa evidente spinta in senso simbolico e naturalistico (che riprende e amplia motivi presenti a San Venanzio, presso il Battistero lateranense), ecco che a San Clemente acquista un ruolo importantissimo la figura umana. Tra i tralci dell’albero della vita si notano uomini intenti a lavorare, il cui valore è esattamente identico a quello dei rappresentanti delle corporazioni che, a Piacenza o a Fidenza, avevano dato i soldi per costruire la cattedrale e si facevano rappresentare sui capitelli delle basiliche. È chiaro che anche a Roma, accanto alla committenza episcopale, esiste una volontà del popolo: l’abside sembra tradire la presenza dei lavoratori che hanno contribuito, anche economicamente, alla realizzazione della decorazione.
La presenza dell’essere umano nelle decorazioni delle chiese romaniche è diffusa in tutta l’Europa, basi pensare al “Ciclo dei Mesi”, attribuibile ad Antelami o alla sua cerchia (a Parma), dove ogni mese è rappresentato da un lavoro manuale, fino alla incredibile e inaspettata redazione del soffitto a buqarnas della Cappella Palatina di Palermo.
Italia meridionale e Sicilia
La situazione meridionale e insulare dei secoli compresi tra il X e il XII è particolarmente interessante. Spesso risolta affermando una massiccia e compatta presenza bizantina, indebolita notevolmente solo con l’arrivo dei Normanni nell’XI secolo, di fatto la realtà appare molto più complessa. In particolar modo il Meridione peninsulare mostra, accanto a monaci di origine siro-palestinese, arrivati nel corso dell’VIII secolo, a causa del fenomeno dell’Iconoclastia, certamente sacche di amministrazione bizantina provinciale, e presenze continue, fluide ma tutt’altro che deboli, di germanici, francesi, longobardi. Questa situazione porta a una complessità linguistica tale che, in mancanza di molti studi specifici, non permette una conoscenza seria della cultura artistica vera e propria e ad una ripetizione, reiterata e semplificata, di relazioni storiche, politiche, economiche ecc, diverse.
Certamente la Sicilia è caratterizzata da una massiccia presenza araba e bizantina; Palermo è la città più araba del Mediterraneo e, il sostrato culturale che ciba i Normanni di seconda generazione (Ruggero II), è una meravigliosa sintesi artistica e architettonica di forte carattere, che si potrebbe definire non tanto bizantino-normanna o arabo-normanna, quanto, in maniera più sensata: siculo-normanna. All’interno di questa impressionante e stupefacente congerie culturale, che produce opere come il Mantello di Ruggero (realizzato da maestranze arabe e bizantine), il Duomo di Cefalù o di Monreale, dove all’architettura monumentale di origine squisitamente francese, voluta dai regnanti, si associano mosaici di chiara derivazione veneto-bizantina, si pone la Cappella Palatina di Palermo.
Cappella palatina di Palermo




.jpg)








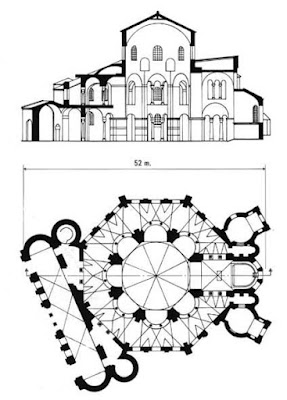
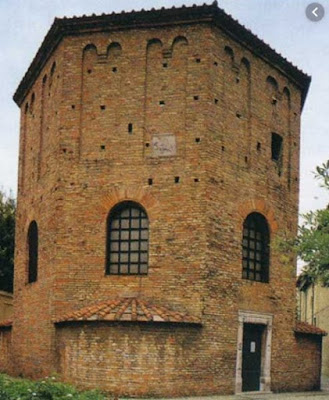
Commenti
Posta un commento